Questo martedì Teresa Siciliano ci parla dello spinoso rapporto fra autori e lettori. Non sempre una passaggiata, soprattutto quando i lettori si fanno un'idea della storia. Quanto un autore deve cedere e ascoltarli?
L'articolo sul blog!
Il rapporto fra chi scrive e chi legge non è sempre facile. Innanzitutto l’autore deve fare i conti con la questione del successo (e del denaro): grandissimi scrittori sono stati quasi totalmente misconosciuti in vita (ad esempio Stendhal) e altri ammirati ed osannati per essere, invece, dimenticati subito dopo la morte (e potremmo menzionare Moravia).
Le cose sono in qualche modo diverse per quanto riguarda i cosiddetti generi di intrattenimento. E questo vale in modo particolare per il rosa, il più bistrattato: infatti, se il giallo e la fantascienza nei loro maggiori esponenti sono ormai entrati a pieno titolo nella letteratura alta, nessuno si sogna di fare lo stesso col rosa.
Perfino gli addetti ai lavori spesso non nascondono una smorfia di disprezzo e tempo fa un importante dirigente editoriale, in un’intervista a Repubblica che non dimenticherò mai, esprimeva una decisa insofferenza per la presenza e l’influenza del rosa sulle statistiche di vendita: diceva che non la quantità di letture conta, ma la qualità e che nessuno potrebbe leggere un romanzo di Gadda in un giorno. Cosa di cui qualcuna di noi, essendo fan sia del rosa che di Gadda, era già ben consapevole.
Negli ultimi anni mi pare che addirittura anche le giovani lettrici non solo usino le espressioni “romanzetto rosa” o “harmony” per liquidare un titolo, ma, salendo per li rami, riversino pari disprezzo sulla Austen o le Brontë. Del resto molti recensori Amazon hanno il coraggio di pensare che, se fossero stati loro a pubblicare Guerra e pace o I fratelli Karamazov, li avrebbero scritti molto meglio. E soprattutto meno mattoni.
In più le scrittrici rosa non possono sperare nella gloria postuma (sempre che ci sia davvero stato qualche scrittore a desiderarlo). Fra le giovani nessuna più compra Liala o Willy Dias o Luciana Peverelli. E perfino noi vecchie appena sappiamo chi era Grazia Deledda, che pure fu insignita del Nobel: io stessa non ho più letto un suo libro da decenni, ormai.
Però a livello di contemporanei il legame fra autori e lettori è sempre molto stretto. Mentre scriveva I misteri di Parigi, Sue era perseguitato da tutti coloro che gli scrivevano per supplicarlo di non, ripeto non, concludere l’opera: volevano che non finisse mai. E tutti ricordiamo Conan Doyle che, odiando a morte il suo Sherlock Holmes, ci provò ad ucciderlo, ma fu costretto a risuscitarlo dalla furibonda reazione dei suoi ammiratori.
Allo stesso modo sui blog noi colloquiamo con le nostre amate scrittrici italiane, per “sgridarle” se i loro romanzi non ci soddisfano del tutto e dare “suggerimenti” sugli eventi futuri nel corso delle serie. Del resto si sa che lo stesso succede agli sceneggiatori delle telenovelas sudamericane e delle soap opera statunitensi, che addirittura commissionano sondaggi fra gli spettatori per decidere certi sviluppi di trama: forse ricorderete, in proposito, il ritorno di Bobby in Dallas.
 Ugualmente potrei elencare le appassionate discussioni via facebook delle fan Mariani, divise fra quelle che, ad esempio, avrebbero voluto una tresca fra Antonio e la Petri e chi, come me, ha evocato i fantasmi di King e di Misery non deve morire, per avvertire la Masella che la morte di Mariani non è un’opzione praticabile, anzi neppure concepibile.
Ugualmente potrei elencare le appassionate discussioni via facebook delle fan Mariani, divise fra quelle che, ad esempio, avrebbero voluto una tresca fra Antonio e la Petri e chi, come me, ha evocato i fantasmi di King e di Misery non deve morire, per avvertire la Masella che la morte di Mariani non è un’opzione praticabile, anzi neppure concepibile.Effettivamente le aspettative sono un problema serio. Già nel rosa vi sono delle strade obbligate: innanzitutto il lieto fine che è obbligatorio e la necessaria presenza di una o più figure eroiche. Naturalmente c’è ancora la libertà di opinione e un’autrice può scrivere quel che le pare, ma sotto pena dell’insuccesso. Inoltre in un caso simile dovrebbe considerare se sia corretto presentare il proprio romanzo come un rosa. Anche se, bisogna ammetterlo, ultimamente i confini fra i generi sono diventati indeterminati. Ma di ciò abbiamo già avuto modo di parlare.
E allora pensiamo al trittico della Ciuffi sui Lykaon, iniziato con il bellissimo Un cuore nelle tenebre, che all’epoca io recensii definendolo un fantasy di alto livello. E scrivevo: “L’autrice individua le coordinate essenziali del mondo dei Lykaon con grande acutezza e sviluppa il filone giallo con notevole abilità, depistando il lettore in modo alla fine sempre giustificato e verosimile. Impeccabile il ritmo narrativo. Si legge d’un fiato. Secondo me, a tutt’oggi il miglior risultato della Ciuffi, nel campo del paranormale, e senza dubbio uno dei migliori in assoluto.”
Nel secondo volume, Un segno nelle tenebre, elogiavo un romanzo d'avventura di buon livello, ma soprattutto l'approfondimento della storia dei lykaon, in parte secondo quanto presentato nel primo volume (per es. l'interclassismo), in parte in modo nuovo, soprattutto per quel che riguardava l'elemento femminile e il rapporto fra generazioni. E non riuscivo chiaramente a immaginare dove sarebbe andata a parare la Ciuffi nella conclusione della saga. Dicevo questo, ma in realtà mi aspettavo che il crescendo progressista sarebbe continuato e l’autrice si sarebbe inventata qualcosa di eclatante. Purtroppo questo qualcosa non venne e per la verità credo che l’autrice non ci avesse mai pensato. Però io, in modo probabilmente ingiusto, rimasi delusissima e mi lamentai del fatto che venissero abbandonate le istanze femministe e si tornasse indietro, alle atmosfere campagnole e tradizionaliste, anziché fare almeno un passo avanti. In questi casi le aspettative personali, a ragione o a torto, compromettono profondamente l’accettazione e la comprensione di un romanzo.
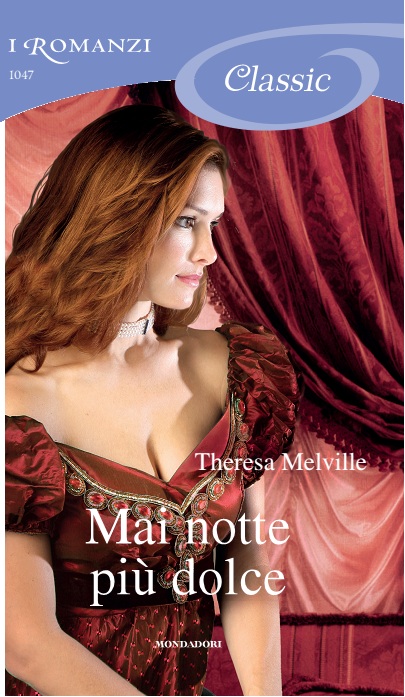 Altro esempio: pensiamo alla serie dei Tourangeau di Theresa Melville, che incappò in tutta una serie di passi falsi (o che tali apparvero a molte lettrici): prima trasformò la protagonista Cornélie in una traditrice di quello che noi credevamo il protagonista della serie, mentre poi risultò essere solo il comprimario, poi addirittura in Mai notte più dolce ammazzò uno dopo l’altro, sia pure nel corso di alcuni decenni, tutti i personaggi. Forse fu trascinata dall’anima noir di M. Teresa Casella o, più probabilmente, voleva dare l’idea che la vita non ha un inizio e una fine, ma è un continuo scorrere. E tuttavia almeno alcune di noi non gliel’hanno ancora perdonata.
Altro esempio: pensiamo alla serie dei Tourangeau di Theresa Melville, che incappò in tutta una serie di passi falsi (o che tali apparvero a molte lettrici): prima trasformò la protagonista Cornélie in una traditrice di quello che noi credevamo il protagonista della serie, mentre poi risultò essere solo il comprimario, poi addirittura in Mai notte più dolce ammazzò uno dopo l’altro, sia pure nel corso di alcuni decenni, tutti i personaggi. Forse fu trascinata dall’anima noir di M. Teresa Casella o, più probabilmente, voleva dare l’idea che la vita non ha un inizio e una fine, ma è un continuo scorrere. E tuttavia almeno alcune di noi non gliel’hanno ancora perdonata. Qualcosa di simile è avvenuto alla Camocardi con la serie delle sciantose. Doveva essere un trittico e all’epoca del primo volume Chi voglio sei tu (senza dubbio il migliore, secondo me) noi lettrici ci eravamo innamorate di un personaggio, Denis, che aveva tratti molto positivi. Ma che cambiò nel corso del tempo, fino ad assumere il ruolo dello stupido cieco che si fa circuire da una donna perfida e ingannatrice, invece di impalmare quella cara al nostro cuore (che comunque si consolava con un altro più intelligente). Bene, a furor di popolo, cioè di lettrici, la Camocardi è stata indotta a concepire un quarto volume in cui Denis riacquista la ragione. Certo sono situazioni cui non è possibile tornare indietro, ma almeno si può trovare un amore più meritevole.
Qualcosa di simile è avvenuto alla Camocardi con la serie delle sciantose. Doveva essere un trittico e all’epoca del primo volume Chi voglio sei tu (senza dubbio il migliore, secondo me) noi lettrici ci eravamo innamorate di un personaggio, Denis, che aveva tratti molto positivi. Ma che cambiò nel corso del tempo, fino ad assumere il ruolo dello stupido cieco che si fa circuire da una donna perfida e ingannatrice, invece di impalmare quella cara al nostro cuore (che comunque si consolava con un altro più intelligente). Bene, a furor di popolo, cioè di lettrici, la Camocardi è stata indotta a concepire un quarto volume in cui Denis riacquista la ragione. Certo sono situazioni cui non è possibile tornare indietro, ma almeno si può trovare un amore più meritevole.E anche la Formenti è passata per questo genere di problemi. Quando nel 2012 uscì il bel romanzo Il destino in una stella, non credo che l’autrice pensasse a dei seguiti e invece l’anno dopo pubblicò lo spin-off Amabile canaglia, che vedeva il cattivo, o presunto tale, del volume precedente, Calozzi, trasformato in protagonista, cosa in verità non rara nel rosa, ma infrangeva varie regole del genere. La storia era imperniata su due sorelle, Amabel, la protagonista, e Pearl, che subito all’inizio incappava in un terribile equivoco e per questo veniva arrestata e deportata in America. Con nostra grande delusione di lei non si sapeva più nulla, mentre intanto si sviluppava la vicenda d’amore fra Amabel e Giovanni, che però era sposato e ciò rendeva impossibile il matrimonio finale. Per cui i due si adattavano ad una convivenza, soluzione in verità non rara in ambito illuministico (basta pensare alla madre di Manzoni), ma che certo per una lettrice rosa era dura da mandare giù. In questa fase la Formenti aveva progettato un trittico: il terzo volume, però, non avrebbe avuto Pearl come protagonista, anche se saremmo state informate della sua sorte, ma una sua figlia, la cui vicenda si sarebbe svolta in contemporanea con la rivoluzione americana.
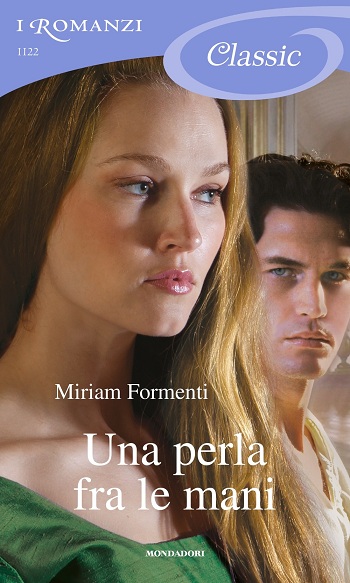 Sul blog Mondadori ci furono polemiche appassionate e non so se a seguito di ciò l’autrice modificò i suoi progetti. Ed ecco qualche settimana fa il bel racconto gratuito Fino al nostro ultimo respiro, dove, a distanza di cinque anni, un annullamento permette a Giovanni ed Amabel di regolarizzare la loro situazione, e poi, soprattutto, soprattutto Una perla fra le mani, in cui ci viene raccontata la storia di Pearl dalla deportazione in poi, in un volume ben costruito, spesso emozionante, ma senza rinunciare al realismo e alla verosimiglianza.
Sul blog Mondadori ci furono polemiche appassionate e non so se a seguito di ciò l’autrice modificò i suoi progetti. Ed ecco qualche settimana fa il bel racconto gratuito Fino al nostro ultimo respiro, dove, a distanza di cinque anni, un annullamento permette a Giovanni ed Amabel di regolarizzare la loro situazione, e poi, soprattutto, soprattutto Una perla fra le mani, in cui ci viene raccontata la storia di Pearl dalla deportazione in poi, in un volume ben costruito, spesso emozionante, ma senza rinunciare al realismo e alla verosimiglianza.Qui ovviamente si apre una questione scabrosa: chi scrive deve venire incontro alle esigenze dei propri lettori? Oppure può tener duro e inseguire il suo concetto di valore e di bello? E ritagliarsi un suo pubblico, educandolo? Un tema stuzzicante e interessante, ma forse sarà meglio rimandarlo ad un’altra occasione.


